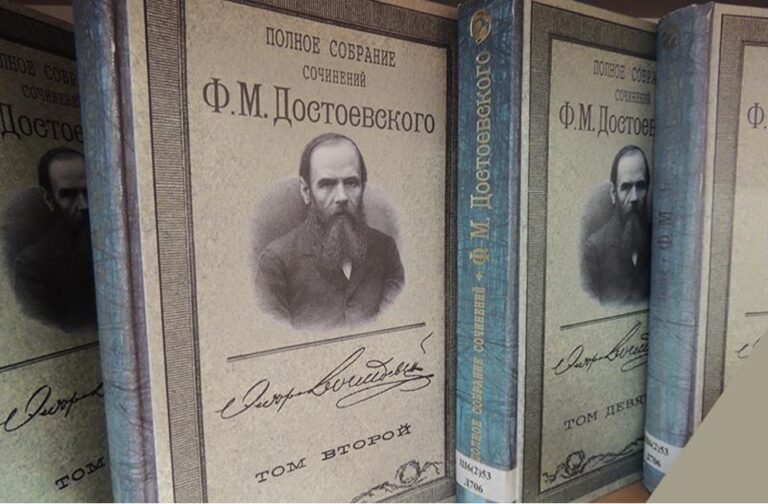“Curioso come a questo mondo ci sia poche gente che ci rassegni a perdite piccole; sono le grandi che inducono immediatamente alla grande rassegnazione”: questa è la frase che lo scrittore triestino Aron Hector Schmitz, meglio noto come Italo Svevo, mette in bocca ad un agente d’affari che tenta di portare ordine in una scombinata storia di figli di papà viziati, ragazze disposte a tanto e una partita da sessanta tonnellate di solfato di rame che attende di essere pagata al porto franco di Sant’Andrea, in arrivo da Londra. Leggere “La coscienza di Zeno”, oltre ad essere piuttosto divertente, è un utile esperienza per passare in rassegna tutto quello che non andrebbe fatto: nella vita, negli affetti e negli affari.
Guido, il cognato nonché socio d’affari del protagonista Zeno Cosini era convinto che sarebbe diventato velocemente ricco e avrebbe dimostrato alla sua famiglia allargata, e alla sua giovane segretaria-amante, tutto il suo valore con un’operazione di arbitraggio internazionale sul solfato di rame.
Grave errore. La prima cosa a cui bisogna pensare è di sbagliarsi, quando si fa un investimento. Faccio fatica a spiegarlo a quelli che mi fanno l’interrogatorio per magari avere una “dritta”, gratis o a pagamento che sia. La verità è che non esistono “dritte” (a meno di quelle che costituiscono reato e che rientrano nella normativa dell’insider trading) e nessuno è in grado di prevedere il futuro.
SPIVA
La “Grande Finanza” è quel settore industriale in cui, negli ultimi 24 anni, per solo tre anni (2004, 2007 e 2009) la probabilità che affidandovi ad un grande fondo avreste fatto meglio dell’indice di riferimento è stata (di poco) superiore al 50%. Nel 2024, ad esempio, il 65% di tutti i fondi attivi – “attivi” nel senso che hanno degli analisti che scelgono gli investimenti per i clienti – ha fatto peggio del mercato.
L’acronimo SPIVA sta infatti per “Standard & Poor’s Indexes Versus Active”: è un confronto dell’andamento degli indici di mercato con, appunto, le gestioni finanziarie attive.
Ma perché questo accade? L’ego dei gestori c’entra, è matematicamente parte del problema. Di norma, infatti, queste persone lavorano in uffici bellissimi che si trovano nei centri delle grandi capitali del business, guadagnano un bel po’ di soldi (milioni l’anno per le posizioni di vertice), e sono circondati da strutture di supporto, informatica, ricerca, marketing e comunicazione che anche loro si prendono una bella parte delle commissioni di gestione che i clienti pagano per il privilegio.
Quello che accade, inoltre, è che per tentare di fare meglio degli indici di riferimento – cosa che andrebbe fatta sia per giustificare la pagnotta che per un motivo di ego: il settore è infatti anche pieno di ranking lists e di serate di gala sempre un tantino sopra le righe che “premiano i top” – le gestioni attive spesso devono spingere il livello di rischio un pochino oltre il consigliabile per la sicurezza degli investitori e questo, se qualche volta può portare dei risultati, su basi statistiche, sul lungo termine, è una losing proposition. Una rimessa, insomma.

So di non sapere
Bingo! Questa la so. Ho fatto il liceo classico.
Applichiamo il concetto ad Eni, ad esempio, di cui abbiamo recentemente parlato. Mettiamo di avere Eni a valore di carico di 13,20 (presente!) e chiediamoci cosa può andare storto e quanto giù può andare il titolo.
Beh, una prima risposta è empirica e basata su un fatto straordinario accaduto di recente: nel 2021, nel pieno del lockdown, il prezzo del petrolio diventò negativo: per qualche giorno, ti pagavano – anche 30 dollari – se ti portavi a casa un barile di oro nero. E cosa fece il titolo Eni in quei giorni? Crollò, certo, ma rimase positivo: raggiunse un minimo di circa 6,5 euro: questo vuol dire che, non alle brutte, ma alle bruttissimissime, rimanete per qualche settimana o qualche mese con un valore di realizzo dimezzato (ma che produce ancora il suo bel dividendo).
Ci sono ovviamente (come per quasi tutte le aziende) tantissime cose che non sappiamo su Eni: i tempi della sostituzione delle vetture a combustione interna, normative ESG sempre più stringenti, i ritorni nel business delle rinnovabili su livelli sempre bassi, o la volontà del Tesoro di continuare a sovra-tassare il business per esigenze di cassa fino ad una “nuova pandemia” che tempo fa veniva da qualcuno che ne evidentemente sapeva data per certa e imminente (un altro pangolino infetto finirà in una zuppa al mercato di Wuhan?).
Rispondendo alla domanda di Socrate, quindi, potremo dire: non sappiamo se abbiamo fatto un grande affare, ma sappiamo che, malissimo che vada, abbiamo un valore di realizzo (immediato) pari al 50% dell’investimento. Non penso che, in ultima analisi, questa sia una situazione diversa da quella di molti proprietari di appartamenti in Italia e non solo, con rendimenti sicuramente inferiori quando ci sono.

Stop loss
L’ego – per tornare all’amico Italo Svevo – è qualcosa che porta anche ad affezionarci a delle idee ed è quasi naturale affezionarsi tanto più a queste si dedica del tempo. Esiste addirittura un concetto di economia comportamentale che spiega il concetto, quello della c.d. sunk cost fallacy, ma non è qui la sede per approfondire.
Basterebbe ricordarsi di tenere sempre sotto controllo il portafoglio e magari inserirsi degli alert su Google che riguardano tutti i titoli che si detengono o che si è interessati ad acquistare per rimanere aggiornati, oppure inserire degli allarmi se il prezzo scende sotto una certa soglia. Quello sarebbe il momento di – qualora si abbia la necessità di limitare la perdita o si intraveda un cambiamento delle prospettive tale da non far intravedere un rialzo dei prezzi nel prossimo futuro – “rassegnarsi alla piccola perdita”, vendere, e magari tenere sempre sotto controllo il titolo per non mandare completamente sprecato il sunk cost, ossia l’investimento che si è fatto in conoscenza e comprensione della situazione.
Secondo Daniel Kahneman, uno dei padri dell’economia comportamentale, il “dolore della perdita è sempre maggiore del piacere del guadagno”. Il differenziale algebrico tra dolore e piacere, se ci pensate, è la misura della ferita dell’ego, che invece di farci badare ai nostri interessi concreti ci porta a dare precedenza al nostro amor proprio e alla nostra presunzione.